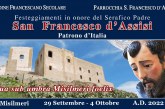I riti pasquali rappresentano un momento assai significativo dell’espressione simbolico-musicale del popolo siciliano. Seppur in differenti fasi dei riti e con diverse modalità esecutive, in molti centri dell’Isola ancora oggi vengono eseguiti canti tradizionali incentrati sulla Passione di Cristo o sulla figura della sua madre “Addolorata”.
A Misilmeri, nella notte tra il Giovedì e il Venerdì Santo, si svolge un tradizionale rito itinerante che prevede l’intervento di diverse “squadre” di cantori che intonano un canto di Passione, intervallandone i distici al suono delle tròcculi (o tabelle). A trucculiata, così come a Misilmeri viene chiamato il rito, si rifà a quelle manifestazioni religiose volute espressamente dalle istituzioni ecclesiastiche ed affidate agli ordini religiosi o alle realtà confraternali per diffondere il messaggio religioso dettato dalla Chiesa. Seppur riplasmato entro contesti culturali diversi, il rito dellatrucculiata ancora oggi conserva le modalità esecutive tradizionali e si mantiene in modo eccellente anche fra le giovani generazioni, le quali sentono di far proprio quanto hanno appreso dai più anziani. Il canto è eseguito da gruppi (dette squadre) di soli uomini appartenenti perlopiù alle varie confraternite del paese. Non manca tuttavia chi per devozione o per tradizione familiare si inserisce nel gruppo dei cantori pur non facendo parte di alcuna confraternita. Ogni squadra prevede circa tre o quattro cantori che si alternano nell’esecuzione, accompagnati da un numero più ampio di suonatori, ognuno con la propria tròccula, scuotendola fra un verso e l’altro del canto.
Le varie squadre si danno appuntamento sul sagrato della propria chiesa di appartenenza per dare inizio al rito. A mezzanotte circa, il cantore più anziano della squadra batte con la tròccula il portale della chiesa per tre volte consecutive, mentre intona le parole: grapi Giuvanni ca lu Signuri è fora. I cantori, quindi, iniziano ad alternarsi nell’esecuzione del canto cercando di rispettare la forma dialogica del testo verbale. Il percorso segue la via rî santi, cioè l’itinerario che solitamente compiono le processioni religiose del paese. È previsto quindi che si canti nei crocevia, davanti alle edicole votive, ma soprattutto davanti alle chiese. Durante il percorso non mancano offerte di bevande (soprattutto vino) alla squadra dei cantori da parte di devoti o delle famiglie degli stessi cantori. La competizione tra le squadre è ancora oggi un tratto evidente dell’intero rituale; ciò si manifesta nel numero dei cantori e dei suonatori, nella presenza di un cantore anziano all’interno della squadra e soprattutto nelle loro qualità canore. Sono soprattutto i cantori più anziani a manifestare ancora oggi quel forte legame devozionale con questi riti, tanto attesi durante l’anno perché ritenuti indispensabili al giusto compimento del ciclo pasquale. Le competenze di ordine espressivo marcano d’altronde l’identità individuale, trasformando questi “esperti” cantori in veri leaders culturali.
Struttura verbale e musicale
L’analisi del testo cantato ha permesso di individuare tre sezioni diverse per forma e contenuto. È bene ricordare comunque che tale divisione non è assolutamente avvertita ne considerata dai cantori che percepiscono invece l’intero canto come un’unica unità formale. Una pur parziale differenziazione avviene però consapevolmente sul versante musicale, durante l’esecuzione.
La prima parte della trucculiata è composta da distici di ottonari a rima baciata il cui contenuto verbale si sofferma sulla figura del peccatore pentito, richiamando i precetti stabiliti dalla Chiesa: la penitenza, il pentimento, il perdono. Costituisce quindi una formula di “chiamata” alle celebrazioni di precetto nel tempo pasquale1.
A questa prima parte segue il tema della cosiddetta “cerca” dell’Addolorata, consistente in una serie di dialoghi tra la Madonna ed altri interlocutori connessi alla Passione di Cristo. Questa seconda parte è costituita prevalentemente da quartine di endecasillabi a rima baciata.
La terza parte consta di pochi distici a rima baciata che concludono l’esecuzione e servono a presentare la squadra, la congregazione o la chiesa di appartenenza. Vengono inoltre aggiunti dei versi che servono ad indicare il luogo in cui si sta cantando o, più spesso, il percorso che seguirà lasquadra per raggiungere il prossimo punto in cui avverrà nuovamente l’altra esecuzione. Il canto determina quindi un percorso sonoro teso a marcare lo spazio urbano, rendendolo “sacro” grazie all’azione rituale annualmente rinnovata.
Musicalmente nel canto possono riconoscersi due moduli melodici sui quali viene intonato. Il primo modulo è perlopiù utilizzato nella prima parte del canto e per la conclusione, mentre il secondo modulo è utilizzato per intonare la parte dialogica, la cosiddetta “cerca”. Il cantore, avvalendosi dell’esperienza ottenuta negli anni, cerca di far collimare il testo verbale con il periodo musicale, servendosi, se lo ritiene opportuno di vocali eufoniche, di brevi melismi soprattutto sulle cadenze intermedie e finali, o di escursioni melodiche nell’ambito della linea principale del canto.
Vogliamo esprimere il nostro sentito ringraziamento e la nostra stima a quanti ancora oggi, con la stessa fede e la stessa devozione, perpetuano questa tradizione lasciataci in eredità da quanti ci hanno preceduto e prima di noi hanno creduto e portato avanti certi valori religiosi e culturali.
1° parte
Veni, veni, o piccaturi,
ca ti voli lu Signuri
Veni prestu e nun tardari
ca Diu ti voli pirdunari
Veni prestu e non del vita,
che non sarà morte infinita
E vinissi cchiù prestu chi sia,
prima chi sona l’Avimmaria
Tu chi dormi ntà stu lettu,
susìti e vâ fatti lu prucettu
E prucettu un ti nni fai,
e a lu nfernu ti ni vai
Tu chi dormi e arripusi,
nun lu sai ca Gesù Cristu è mortu ncruci?
Er è mortu fra pianti e turmenti,
pi sarvari stu populu ignoranti
2° parte
Agghiurnannu lu lùnniri matinu,
la Matri santa si misi in camminu,
la Matri santa si misi in camminu:
iava circannu a lu so figghiu Sarvaturi
La ncontra un vicchiareddu e ci dici:
«c’aviti Matri santa ca chianciti?
c’aviti Matri santa ca chianciti?»
«Haiu persu a lu me figghiu Sarvaturi»
«Va iti arreri i porti ri Pilatu,
lu iti a sciari (truvari) nchiusu ncatinatu,
va iti arreri i porti ri Pilatu,
nchiusu lu iti a sciari ncatinatu»
Tuppì Tuppì «cu è ddocu?» «iu su tò matri»
«forsi è dà sfurtunata ri mè matri,
forsi è dà sfurtunata ri mè matri,
ca va circannu a lu so Figghiu Sarvaturi»
«O Matri Santa nun vi pozzu apriri,
ca li Iurei mi fannu muriri,
o Matri Santa nun vi pozzu apriri,
ca li Iurei mi fannu muriri»
«E vattinni o tu Maria,
vasinnò lassamu a Gèsu e pigghiamu a Tia»
«E macari,e lu facissivu
di lassari a Gèsu e pigghiari a mia»
«Va iti arreri i porti r? chiuvara,
va iti a fari un mazzettinu î chiova,
né tanti logni e mancu tanti fini,
c’hannu a ‘nchiuvari sti carni divini»
«O sur mastru, chi arti vui faciti?»
«Iu fazzu l’arti e di lu firraru»
«E faciti tri chiova pi me Figghiu,
né tanti logni e mancu tanti puncenti»
«Cara Signura si fussi pi mia,
cchiù logni e cchiù puncenti li farrìa»
«Malirittu cu dissi sti paroli,
un diavulu r? nfernu su purtassi via!»
«O sur mastru, chi arti vui faciti?»
«Iu fazzu l’arti di lu mastr r’ascia»
«E faciti na cruci pi me Figghiu,
né tanta longa e mancù tanta gravusa»
«O Signura si fussi pi mia,
cchiù curta e cchiù liggera ci la farria»
«Binirittu cu rissi sti paroli,
un ancilu ri ncelu ci ha mannari!»
«O sur mastru, chi arti vui faciti?»
«Iu fazzu l’arti di lu curunaru»
«E faciti ‘na curuna pi me Figghiu,
né tanta larga e mancù tanta puncenti»
«O Signura si fussi pi mia,
tutta di rosi e ciuri la farria»
«Binirittu cu rissi sti paroli,
un ancilu ri ncelu su purtassi via!»
«O Giura ,o Giura! O trarituri!
Pi trenta ti vinnisti a lu miu Figghiu Salvaturi,
pi trenta tu vinnisti ri dinari:
O Giura, Giura chi vinisti a fari?»
Si tu javi nnì Maddalena,
si vinnìa la capiddera!
Si tu javi nnì Giuvanni,
si vinnìa li mègghiu panni!
Si tu javi nni la Veronica,
si vinnìa la mègghiu tonica!
Si vineva puru nnì mia,
mi vinnìa la mègghiu cutra c’avia!
Se io avrei ti darei i miei gioielli,
se io potrei si darei i miei denari,
e non potrendo ti darei i miei capelli:
O Giura o Giura! chi vinisti a fari?
E li stiddi a lu sirenu,
Gesù Cristu è Nazzarenu
E li stiddi a lu stiddàtu,
Gesu Crisu è carceratu
Passu spissu ri sta strata,
chista è l’urtima chiamata
Sona la tròccula,e affacciati tutti
ca sta passannu la Matri Maria!
E sta passannu afflitta e addulurata,
ca va circannu a lu so Figghiu Sarvaturi
È un vènniri er è di marzu,
quannu murìu nostru Signuri
Er è mortu e a vintunùra
pi nuatri piccatura
E’ di lignu la campana,
Gesù Cristu a tutti chiama
E nni chiama e ad alta vuci,
Gesu Cristu è mortu ‘n cruci
Er è mortu fra pianti e turmenti
pi sarvari stu populu ignoranti
Presentazione della squadra
E scinnemu ri “munti frummentu”
semu a cungrazioni r? Sacramentu
Passu spissu di stu lìsciu
semu a cungrazioni rû Crucifissu
E vinemu di nni Donna Beatrici
stamu smuntannu râ Matrici
Acqua santa Diu la binirici
semu chiddi râ Matrici
Passu spissu ri stu lisciu
stamu iennu a San Franciscu
E niscemu râ porta nova
stamu iennu a chiesa nova
Passu spissu di stu chianu
semu iunti a San Gaetanu
Note
1 In Sicilia è stato documentato un ampio numero di riti di “chiamata” che si svolgevano (e in alcuni casi ancora oggi si svolgono) durante il periodo quaresimale o nel triduo pasquale. Seppure in forme diverse, possono essere ricondotte tutte a un’unica sequenza rituale che prevede l’uso di uno strumento (tròccula, tamburo, tromba) che si alterna a una acclamazione cantata o pronunciata a voce alta da una o più persone (spesso bambini o ragazzi).
 (19)Non Mi Piace
(19)Non Mi Piace (3)
(3)